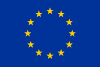2019-10-01 / VLE PAGES
I comportamenti sociali nella comunicazione
Un livello di analisi privilegiato per osservare questa relazione è quello della pragmatica. Tra lingue e culture esistono differenze e analogie di comportamenti sociali e interazionali che si manifestano sul piano linguistico.
Ad esempio, il tipo di relazione che abbiamo col nostro interlocutore può modificare il nostro modo di parlare.
In italiano, segnaliamo se abbiamo un rapporto formale o non formale con il nostro interlocutore attraverso la scelta del pronome: usiamo infatti il tu ad esempio con i nostri amici e il lei con il nostro medico. Tuttavia, per persone che non sono madrelingua, questa distinzione è tutt’altro che banale: se un parlante nativo di italiano sa (quasi) sempre con sicurezza scegliere il pronome più adatto alla situazione, per un parlante straniero non è sempre facile. Per effettuare la scelta migliore, infatti, entrano in gioco una serie di parametri che nemmeno i parlanti nativi saprebbero elencare con precisione ma che, semplicemente, “conoscono da sempre”. Hanno rilevanza, tra le altre cose, la relazione tra le persone, l’età delle persone ma anche la situazione concreta in cui le persone si trovano. Ad esempio, due adulti che non si conoscono e, incidentalmente, si urtano sulla metropolitana, si daranno dei lei; allo stesso modo però, se un adulto chiede ad un altro adulto sconosciuto dove si trovi il bar ad un festival musicale, facilmente sceglierà il tu. Queste scelte su un modo formale o informale di parlare cambiano anche nel tempo all’interno di uno stesso contesto culturale e sociale.
Ci sono poi alcune lingue in cui la relazione sociale che c’è tra i parlanti agisce in maniera ancora più significativa nello scambio comunicativo. Ad esempio, in giavanese, lingua parlata in Indonesia e Malesia, bisogna sempre indicare il rapporto sociale che si ha col proprio interlocutore; una frase con uno stesso significato referenziale (cioè significato concreto) sarà diversa in base al censo, la professione, l’età, la nazionalità e molte altre caratteristiche dell’interlocutore a cui mi rivolgo. Ad esempio, la parola casa sarà tradotta come omah, grija o dalem: le tre parole indicano esattamente lo stesso referente (oggetto concreto) ma la prima si usa se si sta parlando con una persona di classe sociale bassa, la seconda di classe sociale media e la terza, invece, più alta.
Anche per quanto riguarda i saluti, da intendersi come le parole e i gesti che aprono (e chiudono) la conversazione vera e propria, le lingue del mondo si comportano in modo molto diverso. Ad esempio, rispetto alle lingue europee, quelle arabe dedicano molte più parole a questo rituale. Mentre in inglese la conversazione può iniziare dopo un semplice scambio di saluti (-Hello! -Hello!), nell’arabo giordano, più frequentemente, dopo lo scambio di saluti “vero e proprio”, si chiedono informazioni sullo stato di salute dell’interlocutore, dei suoi familiari, si ringrazia Dio e, solo a questo punto, può iniziare la conversazione. Questa pratica, è presente con le medesime caratteristiche anche in wolof, lingua parlata in Senegal; avendo infatti il paese subito una forte islamizzazione, la lingua ha ereditato anche questa pratica comunicativa.
Un altro esempio di pratiche linguistiche molto diverse che coinvolgono la dimensione pragmatica è il rifiuto. In cinese, ad esempio, si evita di rifiutare con un semplice e secco no, ma si usano invece, con la stessa funzione, espressioni come wŏ yŏu shì, traducibile come “ho qualcosa da fare”. A questa frase, non si risponde chiedendo informazioni sui piani futuri, come sarebbe accettabile invece ad esempio in italiano. La risposta è da intendersi in tutto e per tutto come un rifiuto secco.