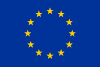2019-10-01 / VLE PAGES
Giustizia sociale
La giustizia e, in particolare, la giustizia sociale, è un concetto alla base della democrazia e dell’educazione ai diritti umani. La giustizia sociale è diventata sempre più interconnessa alle dinamiche globali e ad altri concetti globali ad essa collegati, in particolare l’educazione ai diritti umani(si veda, per es., Agartan, 2014; Banai, Ronzoni, Schemmel, 2011a; Department Of Economic And Social Affairs. Division for Social Policy and Development, 2006). Inoltre, nel settore educativo e dai suoi attori questo concetto è stato utilizzato sempre più spesso (Darling-Hammond, French, & Garcia-Lopez, 2002).
In generale, il concetto di giustizia sociale si riferisce a una distribuzione equa di ricchezza, opportunità e privilegi nella società. Specificamente, la giustizia sociale può essere definita come l’insieme di “principi che definiscono limiti fissi alle ineguaglianze socio-economiche ammissibili, anche se non tutte richiedono una stretta uguaglianza (Banai, Ronzoni, Schemmel, 2011b, p. 59). Nei contesti di vita quotidiana si trovano opportunità di esplorare, fare esperienza e impare qualcosa in più sulla giustizia sociale e su come ognuno sia responsabile della costruzione di un mondo caratterizzato da una distribuzione giusta ed equa di risorse, opportunità e privilegi nella società. Hackman (2005) ritiene che “l’educazione alla giustizia sociale debba includere l’empowerment degli studenti, la distribuzione equa delle risorse e la responsabilità sociale e che i suoi processi includano la democrazia, il focus sugli studenti, il dialogo e l’analisi dei rapporti di potere. La giustizia sociale non prende semplicemente in esame la differenza o la diversità, ma presta molta attenzione ai sistemi di potere e privilegio che generano le ineguaglianze sociali e incoraggia gli studenti a esaminare criticamente i meccanismi di oppressione a livello istituzionale, culturale, individuale, alla ricerca di opportunità di impegno sociale al servizio del cambiamento sociale” (p. 104).
L’autore suggerisce inoltre cinque componenti essenziali dell’educazione alla giustizia sociale:
- padronanza del contenuto
- strumenti per l’analisi critica
- strumenti per il cambiamento sociale
- strumenti per la riflessione personale
- consapevolezza delle dinamiche multiculturali di gruppo
Anzitutto, per partecipare al cambiamento sociale in modo positivo e proattivo, gli studenti devono avere accesso ad ampi e profondi livelli di informazione su questioni locali, nazionali e globali che la società affronta in quel momento e alla contestualizzazione storica, imparando ad esaminare criticamente i contenuti e a dialogare in modo efficace su di essi con gli altri. Tuttavia, la padronanza del contenuto di per sé non è sufficiente a dare luogo a processi educativi democratici e di empowerment. Tenere in considerazione in modo critico e attento le questioni di oppressione, potere e privilegio è necessario per fornire una conoscenza approfondita dei fenomeni e per indicare azioni concrete. Infine, l’auto riflessione critica e continua aiuta a creare un ambiente favorevole all’educazione alla giustizia sociale e all’empowerment. In questo modo, l’educazione alla giustizia sociale può favorire la capacità di azione e incoraggiare i bambini ad attivarsi, partecipare, esprimere e difendere i propri e altrui diritti come parte della loro esperienza quotidiana di cittadinanza. Inoltre, una efficace educazione alla giustizia sociale riconosce le dinamiche di gruppo come il frutto della costruzione di identità sociali e di prospettive multiculturali (Hackman, 2005).
In generale, l’educazione alla giustizia sociale consente ai bambini di imparare:
- come tutti siamo interconnessi
- come mettere in discussione la polarizzazione di punti di vista
- come valorizzare le differenze
- come pensare criticamente a ciò che succede nel mondo e alle comunità in cui viviamo
- come ognuno può essere parte di un processo di creazione di un mondo con maggiore giustizia, uguaglianza e diritti umani per tutti